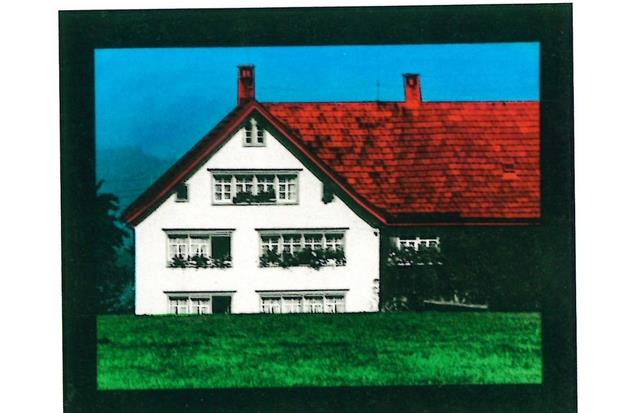Ci sono storie che si tramandano nei secoli e che sconfinano nella leggenda. Esemplare è il caso di santa Caterina d’Egitto, una delle sante più venerate al mondo, a cui sono intitolate chiese addirittura negli Usa e nelle Filippine, luoghi che Caterina nemmeno si immaginava esistessero. Senza andare troppo in giro per il mondo, vicino a Firenze, si trova l’Oratorio di santa Caterina delle Ruote, dove è conservato un ciclo di affreschi del 1300 dipinti da Spinello Aretino, che raccontano le vicissitudini della santa, fra cui il terribile supplizio delle ruote a cui fu sottoposta (e per cui è ancora oggi famosa). In questo ambiente suggestivo, dove è narrata per immagini la storia della giovane Caterina, sarà allestita una mostra di antichi papiri, testimonianze provenienti per la maggior parte dal luogo e dall’epoca in cui “visse” Caterina: l’Egitto attorno all’anno 300 d.C. Le virgolette sono d’obbligo in questo caso, perché le notizie storiche su questa santa sono così incerte, che gli studiosi nel XX secolo (e per primi i Bollandisti, gli 007 dell’agiografia cattolica) hanno messo in discussione la sua esistenza.
La stessa Chiesa in anni recenti ha segnalato che le fonti sono poco attendibili: quindi l’esistenza di santa Caterina d’Egitto è problematica ed è possibile che si tratti di una storia fantastica che si perde nella notte dei tempi. Invece il problema dell’esistenza non si pone per l’Egitto di quei tempi, cioè la società attiva verso il 300 d.C. in particolare nella città di Alessandria, metropoli già famosa e illustre per molte ragioni (basti citare la biblioteca e il faro), prima di essere la patria della nostra santa Caterina. Ecco l’origine del titolo della mostraSanta Caterina d’Egitto. L’Egitto di santa Caterina, allestita proprio all’interno dell’Oratorio di Bagno a Ripoli, che sarà aperta da domani all’11 giugno 2017. L’esposizione, curata dall’Istituto papirologico “Girolamo Vitelli” dell’Università di Firenze, raccoglie documenti risalenti proprio al III e IV secolo d.C. Per quest’epoca i testi scritti su papiro sono abbastanza numerosi e costituiscono fonti di prima mano su molti aspetti della vita quotidiana: per esempio possiamo sapere quanto costava una casa, che cosa portava in dote una giovane moglie, qual era il programma degli spettacoli all’ippodromo e possiamo avere informazioni su tanti altri dati concreti (compreso, ovviamente, quante erano le tasse da pagare, allora come oggi argomento spinoso per tutti). Inoltre abbiamo anche molte informazioni sulla vita culturale dell’Egitto in questo delicato periodo di transizione fra paganesimo e cristianesimo: sono gli anni delle ultime persecuzioni nei confronti dei cristiani, che precedono di poco l’editto di Costantino (313 d.C.) che concederà la libertà di culto in tutto l’impero romano, di cui l’Egitto all’epoca faceva parte.
Come risulta da diverse testimonianze non ci furono solo scontri (ancora circa un secolo dopo, nel 415 d.C., sempre ad Alessandria, la filosofa Ipazia venne uccisa durante tafferugli fra opposte fazioni), ma anche incontri: nelle aule dell’università cristiani e non cristiani insegnavano e studiavano uno accanto all’altro, confrontando le loro idee e le loro fedi. Libri simbolo della cultura greca, come l’Iliade con tutti i suoi dei, e libri contenenti riflessioni sulla nuova religione, come i trattati dei padri della Chiesa, erano scritti e letti dalle stesse persone: in mostra sono visibili testi greci originali appartenenti ad entrambe queste categorie. La figura di santa Caterina, come ci è descritta nei racconti quasi leggendari molto diffusi dal medioevo in poi, è perciò collocabile in un contesto storico molto preciso attraverso i papiri, ma anche attraverso i reperti archeologici, cioè oggetti concreti, come vestiti, contenitori e giocattoli risalenti a circa 1700 anni fa, e recuperati da scavi in Egitto. Si tratta di prodotti simili a quelli con cui una ragazza, ricca, elegante ed istruita, come Caterina, avrebbe potuto avere a che fare: reperti preziosi e testimonianze uniche che gli esperti del-l’Istituto papirologico di Firenze sono in grado di connettere fra loro e di collocare nello stesso contesto sociale, religioso e storico. Il fascino della storia, insomma, prima che si trasformi in leggenda. Un episodio su tutti: il momento terribile del supplizio inflitto alla giovane, il tormento delle ruote, è raccontato attraverso le immagini dei dipinti dell’Oratorio ed è parallelamente narrato attraverso le parole di un frammento di papiro in greco del 500-600 d.C. Ecco perché venire a visitare una mostra di questo tipo: per comprendere il valore di reperti unici e non sempre accessibili (come la trentina di papiri greci esposti e gli altrettanti oggetti provenienti da scavi archeologici di solito chiusi in magazzini) e per compiere un viaggio in un mondo lontano, ma ricostruito in tutti i suoi vividi dettagli e secondo angolature differenti.
da Avvenire